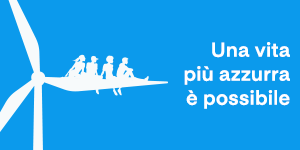Da venerdì 17 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Maradona y Pelé”, il nuovo singolo dei Thegiornalisti.
Il brano, in uscita su etichetta Island Records, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust (Dario Faini), segna una nuova pagina nella storia del gruppo, che entra ufficialmente nel roster di Universal Music.
Con queste parole, Tommaso Paradiso descrive il pezzo:
“Maradona y Pelé l’ho scritta in momenti diversi, un po’ come è stato per Completamente. Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme. Il primo seme è stata questa immagine di “labbra” stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo, insonne; e allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei. Però mi mancava sempre qualcosa, non volevo chiuderla così. Per cui mi son detto “devo metterci qualcosa di assolutamente evocativo, assolutamente mio e assolutamente romantico: Robert de Niro, l’attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l’acqua santa del più gioco più bello del mondo”.
THEGIORNALISTI, NUOVO SINGOLO “MARADONA Y PELE'”
CANNES, APRE “I MORTI NON MUOIONO” DI JARMUSH
Una Spoon River alla fine del mondo è il dono d’apertura che Jim Jarmush fa al 72 Festival di Cannes: “I morti non muoiono” si è offerto alla soirée d’ouverture della kermesse spalmando sulla Croisette un clima stranamente soft, da commedia umana malinconica e dolente, un puro zombie movie che tinge di venature liricamente surreali l’iconografia classica dei morti viventi alla George Romero. È una sorta di riscrittura horror di una mitologia americana incarnata nell’epitaffio stralunato degli avi dimenticati, resuscitati da Jarmush come testimoni della non vita alla quale siamo ormai tutti condannati.
L’impianto è prettamente di genere: una cittadina di provincia, la varia umanità che ruota attorno al bar, alla stazione di servizio, allo spaccio, alla centrale di polizia… In tv si parla dello spostamento dell’asse terrestre causato da una sconsiderata operazione di fracking sui ghiacciai polari e infatti il sole non tramonta più, la luna emana strani bagliori, il tempo s’è fermato e, nel cimitero, la terra che ricopre le tombe si smuove, sputando tra i viventi i corpi ritornanti dei morti. Che brancolano affamati e divorano i vivi. I primi due zombi sono Iggy Pop e Sara Driver, poi altri ne arrivano, di ogni foggia età ed estrazione, lasciando interdetti il capo della locale polizia Bill Murray e il suo vice Adam Driver, che poco possono fare se non guardarsi attorno stupiti e ripetere che c’è qualcosa di strano…. Jarmush illustra la classica materia narrativa horror come fosse un racconto di fiabe raccontato con ironia, dando forma alle paure come fossero sogni sospesi sul loro significato. Insomma il suo solito universo distratto e indolente, calato in una scena horror classica…
In “I morti non muoiono” le cose accadono perché sono scritte nel destino di un’umanità che ha segnato la sua fine, fatalmente. La paura che nutre la materia horror e ribaltata dal regista nella traccia di una poesia malinconica che contempla con rassegnazione i segni della fine del tempo. Bill Murray e Adam Driver sono il baricentro surreale di una comunità che incarna le figure classiche della tradizione americana: c’è il fattore reazionario interpretato da Steve Buscemi, c’è il vecchio nero tuttofare Danny Glover, c’è l’agente di polizia Chloe Sevigny. E poi ci sono i due outsider per eccellenza: Tilda Swinton, surreale proprietaria del locale obitorio che maneggia la sciabola con straordinaria maestria, e il barbone del posto Tom Waits, che vive nei boschi e tutto osserva da lontano, attraverso le lenti rotte di un vecchio binocolo. “I morti non muoiono” è esattamente quello che annuncia l’allitterazione fonetica del titolo originale (“The Dead Don’t Die”), una sorta di filastrocca intristita, in cui l’ironia rasenta il sarcasmo e la malinconia si dimentica della dolcezza, lasciando l’amaro in bocca: si ride, si resta sorpresi per un paio di sortite surreali che Jarmush si concede (da non rivelare per evitare i danni da spoiler), qua e la si percepisce qualche caduta di tensione: siamo in realtà lontani dagli esiti perfetti di capolavori jarmushani come “Paterson”, “Ghost Dog” o l’altro horror “Solo gli amanti sopravvivono”. Ma “I morti non muoiono” rimane di sicuro come il film più duro, triste e spietato di questo poeta della macchina da presa, quello in cui si canta la pietà per quei morti che sembriamo un po’ tutti noi, all’alba dei nostri giorni.
cau
A CANNES LES MISERABLES, TENSIONI SOCIALI A PARIGI
Dall’alto dei cieli, ovvero la banlieu parigina dalla prospettiva del drone: siamo a Montfermeil, lì dove Victor Hugo trovava i suoi Miserabili e dove il filmmaker francese Ladj Ly piazza la macchina da presa del suo primo film di finzione, ovviamente intitolato “Les Misérables”. Il Concorso di Cannes 72 butta subito nella mischia il cinema francese e lo fa affidandosi questo esordiente che viene dal basso, con lunga pratica di documentarista, esercitata da tempo proprio sulle strade della periferia parigina, filmando per un anno intero la vita a Clichy-Montfermeil, il quartiere nella periferia nord di Parigi, dopo la sommossa del 2005, scoppiata a seguito della morte di due adolescenti. La sua è un’esperienza di cinema di strada che arriva da lontano, iniziata addirittura nel 1995 accanto a Romain Gavras, il figlio di Costa-Gavras, col quale aveva fondato il collettivo Kourtrajmé impegnato a fare cinema coi giovani del quartiere, ma non è da dire che Ladj Ly giunga alla selezione di Cannes 72 con un film sperimentale: “Les Misérables” corrisponde pienamente alle necessità di quel cinema d’impegno civile anabolizzato dall’industria cinematografica francese, al quale siamo abituati sulla Croisette.
L’attenzione per il mondo dell’adolescenza resta però forte, perché il film è un tracciato corale in cui le tensioni della banlieu si intrecciano tra sistemi di potere incrociati, ma finiscono col tenere sotto pressione quell’infanzia che avrebbe il diritto di giocare per strada senza dover temere di interferire con gli equilibri di potere. La storia è un apologo scritto sul confronto tra la legalità e l’ordine, in cui una pattuglia composta da tre agenti della brigata anti-crimine, cercando di risolvere il caso di un cucciolo di leone rubato da un ragazzino dalle gabbie di un circo, finisce con l’innescare un circolo pericoloso di violenza: gli zingari del circo pretendono la restituzione dell’animale, il boss del quartiere non vuole collaborare, il capo della moschea cerca di difendere il ragazzino la cui bravata ha provocato il danno…
Quando la situazione sfugge di mano ai poliziotti e un altro ragazzo filma col drone la scena che potrebbe scatenare il putiferio, l’urgenza degli adulti di mettere ordine nelle cose finisce col lasciare i ragazzi del quartiere soli, orfani del senso di giustizia che dovrebbe reggere le cose e pronti a scatenare la loro rabbia. Il regista insiste con spirito da presa diretta sulla scena della banlieu che ben consce, cercando proprio nell’idea di un mondo degli adulti che impone la violenza sulla quotidianità di strada la chiave di accesso all’innocenza perduta di un intero sistema sociale, in cui l’infanzia è violata senza rendersene conto. Intensità, ritmo, un finale inquietante, interpreti che reggono il gioco di un realismo implicito: “Les Misérables” sa fare il suo lavoro e non la manda a dire a ogni sistema di potere, legale o meno, che pretende di gestire l’ordine prescindendo dall’innocenza che la giustizia deve conoscere e preservare.
cau
A CANNES “SORRY WE MISSED YOU” DI KEN LOACH
Immancabile sulla Croisette, Ken Loach giunge nel Concorso di Cannes 72 con “Sorry We Missed You”, il nuovo capitolo di quello che è ormai un vero e proprio trattato di umanesimo al tempo dei forzati del lavoro, scritto a quattro mani con l’inseparabile Paul Lavery. Questa volta la scena sociale è offerta dal mondo degli spedizionieri, quei moderni cavalieri delle consegne in 24 ore, sulla cui pelle si giocano urgenze e conseguenti concorrenze di buyer e seller grandi e piccoli. Nel mondo globalizzato della fretta come categoria di discernimento, sono queste persone, che ogni giorno attraversano le nostre città e bussano alle nostre porte con le consegne, a patire sulla loro pelle il peso di un lavoro massacrante: eccolo dunque il nuovo eroe di Ken Loach, il suo nome è Rick Turner ed è interpretato con la immediatezza da Kris Hichen, ancora un volto poco noto, apparso quasi vent’anni fa tra i lavoratori di un altro capitolo loachiano, “Paul, Mick e gli altri”. Rick è un padre di famiglia che, in cerca di lavoro dopo l’ennesimo licenziamento, compra in leasing un furgone e entra in un franchise di consegne a domicilio. Niente stipendio fisso, ma guadagno sulla base del lavoro svolto, ergo lavorare 14 ore al giorno per poter pagare i debiti fatti per iniziare a lavorare.
Lui si mette al volante di buona lena, pazienza che per prendere il furgone ha dovuto vendere la macchina con la quale la moglie, infermiera a domicilio, andava a lavoro. La donna accetta di girare per la città in bus, e le scene che la vedono portare a casa della gente assistenza, salute, sorrisi e solidarietà sono un bel contrappunto a quelle che mostrano Rick bussare alle porte per consegnare i suoi pacchi. Il film racconta presupposti e conseguenze di questa situazione con precisione, ma Loach in realtà usa questo scenario da moderni schiavi del lavoro come setting per quello che poi viene sviluppato piuttosto come un dramma familiare. Perché è la vita quotidiana delle persone a pagarne le conseguenze vere, sono i problemi provocati dal figlio adolescente che si fanno sentire, la tensione cresce proprio nell’impossibilità di essere presenti alla propria esistenza, alle urgenze di consegna delle attenzioni quotidiane. In questo senso “Sorry We Missed You” ha una marcia in più rispetto ad altri simili lavori di Loach, perché costruisce uno scenario più intimo, basato su personaggi che si sforzano non solo di trovare una via d’uscita al sostentamento quotidiano, ma soprattutto di aderire con sincerità alla loro dimensione umana. Così il film procede senza picchi particolari, ma con una sincerità che sino a due terzi lo preserva dall’inevitabile già visto loachano.
cau
CANNES, ALMODOVAR COMMUOVE CON “DOLOR Y GLORIA”
Il dolore e la gloria, come due facce della stessa medaglia sul petto del grande Pedro Almodovar, che torna puntuale sulla Croisette con il suo nuovo film, il più autobiografico di una carriera tutta costruita sulla rifrazione tra vita personale e arte offerta al mondo. E c’è commozione a Cannes per “Dolor y Gloria”, un sentimento diffuso di rispetto e partecipazione di fronte a un’opera che, nella capacità di affabulare il percorso di una vita senza vestire l’autobiografismo immediato, riesce a trovare il tono di una sincerità disarmante e fiduciosa nell’affetto del pubblico. Applausi condivisi sulla Croisette e in gran parte del mondo (Italia compresa) dove il film viene lanciato in contemporanea con la presentazione nel Concorso di Cannes 72, a un paio di mesi di distanza dal successo con cui è stato accolto dal pubblico in Spagna. “Dolor y Gloria” è una sorta di quaderno delle rimembranze almodovariane, che si affida alla figura di un famoso regista spagnolo di nome Salvador Mallo per raccontare, tra allusioni e illusioni, quello che è stato il suo percorso umano ed artistico. Non tanto gli eventi precisi, ma le suggestioni, gli stati d’animo, le sofferenze fisiche e spirituali, gli amori trovati, vissuti e persi, messi in scena nella tarda prospettiva di Salvador, un regista ormai inattivo e in crisi, interpretato dall’immancabile alter ego almodovariano, Antonio Banderas, con una intensità sobria e profonda che ne fa forse la migliore prestazione della sua carriera.
Salvador vive chiuso nella sua casa museo, stretto nella solitudine e aggrappato ai dolori fisici che lo attanagliano. La cineteca ha restaurato un suo vecchio capolavoro e per lui è l’occasione di ricucire lo strappo che aveva consumato all’epoca col suo attore preferito, Alberto. Ma il passato è per lui un fiume in piena che porta con sé i ricordi dell’infanzia, dell’amatissima madre, dei suoi primi desideri sessuali, del suo unico grande amore perso. Il film ha una tessitura a trama larga, un intreccio vago di ricordi che si succedono nella mente e nel corpo dolorante che Salvador cerca di tenere a bada con l’aiuto delle droghe. Il punto focale del film resta l’atto del ricordare, il valore del rivivere gli eventi trascorsi per mettere ordine nei sentimenti confusi e provare a raccontarli in quello che è poi il film che stiamo vedendo. La sincerità e la menzogna sono gli estremi che si toccano per costruire un arco esistenziale in cui Almodovar raggruma il senso stesso del suo filmare. Il film è alto nella sua semplicità, universale nella capacità di ritrovare il dettaglio, la luce di una memoria, i colori di una casa. La riconciliazione con se stessi, sembra dire Almodovar, passa per la capacità di narrarsi non tanto con sincerità, quanto con verità artistica. L’affabulazione, l’atto creativo, la scrittura, il disegno sono il punto fermo di quel flusso continuo di coscienza e di incoscienza che è l’esistenza. La traccia che resta. E “Dolor y gloria” sa farsene carico con una perfezione di messa in scena che fa ritrovare il miglior Almodovar da lungo tempo a questa parte.
cau
“DIEGO MARADONA” A CANNES, KAPADIA RACCONTA IL MITO
Questa volta il pibe de oro sulla Croisette non c’è stato, Cannes 72 ha dovuto fare a meno della sua preseza sulla Montée des Marches di “Diego Maradona”, il documentario di Asif Kapadia presentato fuori concorso. Non era stato così undici anni fa, nel 2008, quando il festival aveva presentato un altro documentario sulla star del calcio “Maradona di Kusturica”, più che altro un ritratto firmato dal grande regista serbo, e il pibe aveva fatto spettacolo di sé. Ad ogni modo, l’hype sulla Croisette non è certo mancato, come sempre Maradona attira l’attenzione di fan, sportivi e media, tanto più che questa volta si tratta di un lavoro di repertorio, firmato da uno dei più apprezzati ritrattisti del documentario contemporaneo, l’inglese Asif Kapadia, al quale si devono i premiati lavori su Ayrton “Senna” e su “Amy” Winehouse.
In “Diego Maradona” Kapadia ricostruisce la vita e la carriera del pibe partendo da oltre 500 ore di materiale di repertorio, senza aggiungere interviste originali, ma solo lavorando su un apparato iconografico che, conoscendo la ben nota disponibilità di Maradona a farsi riprendere, non è certo scarso né di scarsa qualità. Il film è una cavalcata attraverso l’ascesa, la grandezza e la decadenza del mito del pibe de oro, con una ampia parte dedicata ovviamente ai sette anni trascorsi a Napoli, sul campo e nella città.
Le immagini ricostruiscono la sua infanzia, quella di un ragazzino povero cresciuto tirando calci a una palla tra le baracche di Buonos Aires e arrivato ad essere la star mediatica mondiale che è stato, capace di incantare sul campo di calcio e di crollare nella vita privata. Il film si offre come un ritratto capace di affascinare chi generazionalmente è cresciuto nel mito di Maradona e di raccontare adeguatamente a chi non c’era la sua storia e la risonanza sociale avuta in tutto il mondo e in Italia particolarmente. Kapadia focalizza la sua attenzione sulla parte che considera “la più intensa sia come uomo che come calciatore”, i sette anni trascorsi a Napoli, che lo portarono al top della scena mondiale, ma che lo coinvolsero in un clima che fu capace di segnarlo negativamente. Al film Maradona non ha preso parte personalmente, ma il suo coinvolgimento è stato in qualche modo ufficiale, se non altro per permettere alla produzione di attingere al grande archivio di immagini del calciatore. Kapadia ha trascorso diciotto mesi a parlare con Maradona, scavando nella sua storia e nella sua personalità. E le immagini più sorprendenti che il regista è riuscito a trovare, come dice lui stesso, sono quelle di un vecchio video commissionato dal primo agentedi Diego a due cameraman argentini negli anni ’80: i due filmarono il giovanissimo calciatore quando ancora era un ragazzino e giocava per il Boca Juniors, con l’intenzione di farne già allora un film per il grande schermo. Insomma le stimmate della star nei piedi di un calciatore.
cau
CANNES, MATTOTTI RACCONTA INVASIONE ORSI IN SICILIA
Marciano sulla Croisette gli orsi siciliani di Buzzati e Mattotti, prendendo la montée des marches parallela, quella della competizione del Certain Regard e incantando il pubblico di Cannes 72 con la forza di una antica fiaba sospesa tra apologo sull’ambiguità umana e metafora sui destini dell’Europa e del mondo. Quando fu scritto da Dino Buzzati, nel 1945, per essere pubblicato a puntate sul Corriere dei Piccoli, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” divenne subito un successo, ma non ebbe vita troppo facile perché sembrava parlare troppo direttamente di quei tempi: la città degli uomini ricordava troppo Berlino e gli orsi non erano da meno. Poi, quando alla fine degli anni ’50 Buzzati lo riprese e lo completò, qualcuno vi lesse invece una metafora del terrore d’invasione comunista…
Tutte letture che a Mattotti interessavano poco. E infatti ciò che resta oggi è una fiaba che parla sì del potere, ma soprattutto della capacità di instaurare un rapporto di fiducia tra gli esseri, sulla relazione tra le civiltà e la natura, sul bisogno di confrontarsi a cuore aperto con gli altri. Ed è su questo versante che Lorenzo Mattotti si è impegnato nel lungo lavoro, durato sei anni, che ha condotto sul testo di Buzzati, consegnandoci ora un film d’animazione che è perfettamente coerente sia con la poetica buzzatiana sia con il suo stile di disegnatore. Eccola dunque la storia di Leonzio, il Grande Re degli Orsi, che per ritrovare il figlio Tonio decide di condurre a valle il suo popolo, verso il regno degli uomini governato dal vanitoso e malvagio Granduca. Le sue intenzioni sarebbero pacifiche, ma la reazione violenta dei soldati lo porta a conquistare la città e a instaurarvi un regno giusto e felice di pacifica convivenza, potendo contare anche sull’aiuto del mago De Ambrosiis e sulla vicinanza del ritrovato Tonio, che era finito a fare l’equilibrista in un circo. Non tutto però va per il verso giusto, perché i regni felici non esistono e la corruzione delle anime è sempre in agguato, sicché la convivenza tra uomini e orsi mette in moto ambizioni, tradimenti, gelosie e soprattutto l’incomprensione tra Leonzio e Tonio, tutte cose che porteranno a gravi conseguenze.
Mattotti lavora sul suo solito stile fortemente inventivo, basato su linee e cromatismi netti e precisi, poco sfumati ma capaci di rendere il doppio fondo tra mondo reale e accensioni visionarie con una incredibile capacità affabulatoria e simbolica. Non mancano i rimandi figurativi d’epoca, come quelli all’espressionismo tedesco che emergono da alcuni fondali e soprattutto dal disegno del mago De Ambrosiis, ma ciò che colpisce del film è la forza immaginifica che tiene insieme le grandi scene di massa e il gioco di relazione tra i personaggi. Si impongono le sequenze fantastiche, come gli scontri di massa tra gli orsi e il Gatto Mammone o il temibile Serpente Marino, o le accensioni notturne sulla presenza degli spiriti degli orsi morti. Mattotti insomma crea un universo figurativo concreto e fantastico allo stesso tempo, tenendo fede alla portante simbolista e metafisica del suo stile, grazie alla quale dialoga apertamente con lo spettatore di ogni età, attivando la sua fantasia e preferendo “lasciargli la possibilità di evocare e arricchire il proprio immaginario, la propria visione personale”, dice Mattotti: “Sono cresciuto così, tutti gli autori che mi hanno appassionato sono quelli che mi hanno lasciato sognare e immaginare a modo mio, che mi hanno arricchito attraverso l’immaginazione”.
Il lavoro di adattamento del testo di Buzzati è stato del resto lungo e articolato, Mattotti ha cercato la collaborazione di due sceneggiatori francesi non soliti al cinema di animazione, Thomas Bidegan e Jean-Luc Fromental, con i quali ha cercato di circoscrivere la narrazione su alcuni personaggi più focalizzati rispetto a quanto accade nella fiaba di Buzzati, immaginando anche la cornice offerta dal cantastorie Gedeone e dalla sua piccola assistente Almerina, che punteggiano la narrazione rievocando gli eventi per il Vecchio Orso trovato nella caverna.
Il tutto retto poi dalla recitazione affidata ad attori come Toni Servillo, che dà voce a Leonzio, Antonio Albanese, che è il cantastorie Gedeone, Corrado Guzzanti che è Salnitro e persino Andrea Camilleri, che interpreta il Vecchio Orso al quale viene raccontata la storia. Il film, che è una coproduzione italo-francese, sarà distribuito in Italia da Bim, presumibilmente in contemporanea con l’uscita francese, che è fissata a fine ottobre.
C’ERA UNA VOLTA… A HOLLYWOOD, TRAILER FILM DI TARANTINO
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie protagonisti di C’era una volta… a Hollywood, il nono film diretto da Quentin Tarantino. Ambientato nella Los Angeles del 1969, il nuovo lungometraggio del regista e sceneggiatore premio Oscar segue le vicende dell’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). I due cercheranno di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. La pellicola, presentata oggi a Cannes, arriverà in sala il 19 settembre.